La rivista
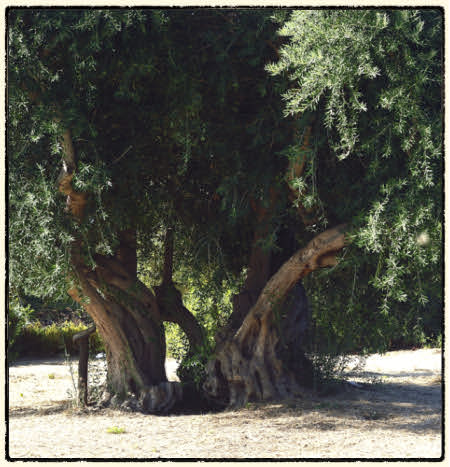
n. 6giugno 2025
Si vede bene solo col cuore
Educare in contesti di vulnerabilità. Una sfida pedagogica e politica
Nell’opera Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry, il celebre aforisma “Si vede bene solo con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi” invita a guardare oltre la superficie, ad accogliere l’altro nella sua unicità e profondità. Questo messaggio, universale e senza tempo, trova una potente risonanza nel campo educativo, specialmente quando si opera in contesti di vulnerabilità sociale.
La vulnerabilità, che si manifesta attraverso povertà, esclusione, marginalità e precarietà, rappresenta una sfida cruciale per chi educa. Ma al tempo stesso, questi contesti offrono spazi per pratiche pedagogiche trasformative, in cui la relazione, l’ascolto e la comprensione profonda possono dare forma a svolte educative illuminanti. La riflessione teorica e pratica sulle esperienze che emergono in questi luoghi può rappresentare una chiave per riaccendere un’umanità talvolta interrotta, creando ponti di solidarietà e speranza. Allo stesso tempo, tale categoria e lente privilegiata di riflessione e azione pedagogica rischia di intrappolare le soggettività in possibili percorsi e interventi educativi stereotipati e stereotipanti se non utilizzata con sguardo critico e all’interno di prospettive che restituiscono storicità ai soggetti.
Questo numero monografico propone saggi che esplorano tutte queste questioni con proposte di carattere teorico-fondativo ed esperienze e pratiche educative.
Buona lettura!
La foto di copertina è di Giovanni Carbone. Si ringraziano Giorgio Crescenza, Alessandro Ferrante e Lisa Stillo, editors del monografico e tutti gli autori che hanno inviato i loro contributi.
indice
Vite vulnerabili e mondi educanti: per una pedagogia della cura
Il contributo muove da una breve analisi delle criticità presenti sui diversi piani dell’esistenza umana, in cui sempre più gruppi sociali sono esclusi e vivono condizioni di marginalità e vulnerabilità. A partire da tale contestualizzazione si intende ragionare sul costrutto di vulnerabilità in una prospettiva pedagogica critica, al fine di decostruire pericolose visioni omologanti e stereotipate che rischiano di enfatizzare e riprodurre condizioni di esclusione, piuttosto che ripensare la vulnerabilità come atto politico e spazio del possibile. Si tratta di educare a uno sguardo profondo, attraverso il ripensamento delle parole e la costruzione di contro-narrazioni che supportano mondi trasformativi, attraverso cui “vedere con il cuore” e ridefinire lo spazio di azione della relazione di cura.
Corpo, potere e educazione: le sfide per una convivenza ecologica
In che modo il corpo può costituirsi come soggetto cardine nella costruzione di una convivenza ecologica e responsabile? Il testo analizza le diverse declinazioni che può assumere la relazione tra corpo, potere e educazione, con un focus sulle traiettorie delineate dall’embodied cognitive science. Se da un lato i dispositivi formativi possono riprodurre meccanismi di controllo e disciplinamento, dall’altro la prospettiva dell’embodied mind conferisce nuovi significati alla corporeità e al movimento, permettendo una lettura relazionale dell’esperienza umana. Il corpo, attraverso le sue possibilità esplorative, partecipa alla trasformazione della realtà insieme all’altro, condividendo la propria vulnerabilità.
L'approccio educativo alla vulnerabilità. L'esempio della povertà educativa
ll contributo si propone di approfondire in chiave pedagogica il tema della vulnerabilità. Questo sguardo supera la centratura sulla dimensione individuale di tale condizione incentivata dal paradigma neoliberale, e la interpreta come una situazione appresa frutto dell’interazione tra il soggetto e il contesto sociomateriale di riferimento. All’interno di tali riflessioni, verrà approfondito il fenomeno della povertà educativa come caso di studio a partire dal quale ripensare da una prospettiva educativa le strategie di intervento verso le situazioni di vulnerabilità.
Vulnerabilità e comunità: educazione, relazionalità, resistenza sociale
La vulnerabilità è un elemento fondante dell’esistenza umana e un principio pedagogico ed etico per la costruzione di comunità solidali. Il saggio analizza il ruolo dell’educazione nel trasformare la fragilità in risorsa, promuovendo un’azione politica basata sulla cura e sulla relazionalità; indaga la connessione tra vulnerabilità e solidarietà politica, mettendo in luce come i movimenti sociali e le pratiche educative possano costituire strategie di resistenza alle forme di esclusione e oppressione contemporanee.
Ri-pensare la vulnerabilità tra adattamento e trasformazione
Il contributo propone una riflessione critica sul concetto di vulnerabilità, esplorandone le implicazioni pedagogiche alla luce delle nozioni di resilienza e resistenza. Dopo aver osservato alcune interpretazioni semantiche e teoriche della vulnerabilità, l’articolo discute le ambiguità e il potenziale uso strumentale in ambito sociale ed educativo della resilienza: seppur utile, infatti, rischia di diventare un dispositivo di accettazione dell’inaccettabile. Su questo versante, invece, il concetto di resistenza sembra offrire uno spazio generativo per un’educazione emancipativa. Il suo valore euristico è capace di riconoscere la vulnerabilità come terreno di possibilità e trasformazione, uscendo dalle ricorsive maglie di percorsi stereotipati contaminati dal solo adattamento.
Educazione come pratica di liberazione: umanità, inclusione, vulnerabilità
L’educazione si configura come un atto di responsabilità e come pratica di liberazione intergenerazionale. La politica educativa attuale promuove, mediante progetti e iniziative quali la public history, le reti di mutualismo e i Centri di Aggregazione Giovanile, un approccio intersezionale all’inclusione, il dialogo interculturale e la resilienza. Il presente contributo si sofferma sull’opportunità di ri-orientare e ri-definire gli interventi educativi nei contesti di vulnerabilità sociale. In tale prospettiva si delinea l’esigenza di realizzare modelli educativi che favoriscono un’evoluzione collettiva e che diano origine a svolte educative innovative, per erigere reti di solidarietà e fiducia per il futuro delle comunità più vulnerabili.
Vulnerabilità e cura dell'altrƏ: riflessioni pedagogiche ai margini
Attraverso il dialogo tra i contributi teorici di Judith Butler e bell hooks – che riflettono rispettivamente sulla comune esposizione alla precarietà e vulnerabilità delle esistenze, e sulla cura educativa come strumento di resistenza capace di trasformare e sovvertire le strutture di potere oppressivo – si intende proporre un posizionamento pedagogico ai margini. Tale posizionamento, riconoscendo la necessità esistenziale di una vita comune, intende assumersi la responsabilità educativa e politica di una cura che vada oltre l’assistenzialismo e il paternalismo, favorendo una sua comprensione come dispositivo in grado di sostenere pratiche di partecipazione, ascolto, pensiero critico e sovversione delle strutture di potere oppressivo.
Sostenere bruchi per (ri)dar vita a farfalle: un'educazione fatta di relazioni
Nell’oggi di una vulnerabilità sociale conclamata, determinata in parte da politiche educative e di welfare nei confronti di soggetti più fragili, la Pedagogia è chiamata a predisporre dispositivi volti a colmare il divario tra uomini, donne e bambini per la costruzione di un domani più giusto. Intrecciare narrazioni individuali e collettive sembrerebbe la chiave di volta di una proposta educativa liberatoria (Freire, 1970) mirante a costruire coscienze critiche rivoluzionarie. Parrebbe necessario, di conseguenza, usare il cuore nell’avvio di processi trasformativi genuini che conducano gli uomini a guardare nella stessa direzione: quella di una società eterogenea in cui a tutti siano garantite le stesse possibilità di stare al passo, coniugando la logica della redistribuzione a quella del riconoscimento (Alietti, 2022).
Tra pedagogia clinica e neurologia: la "cura" per il soggetto con Alzheimer
Il contributo propone una riflessione teorico-pratica sul ruolo della Pedagogia Clinica nella “cura” del soggetto affetto da Malattia di Alzheimer. Attraverso l’analisi del dialogo tra sapere pedagogico e sapere medico, si evidenzia come il soggetto-paziente rappresenti una forma complessa di vulnerabilità esistentiva. L’articolo mostra come la relazione educativa, il riconoscimento della soggettività e la consulenza pedagogico-clinica possano generare processi trasformativi che restituiscono senso all’identità nella malattia.
Un'esperienza educativa nella borgata romana di San Basilio
L’articolo ricostruisce l’esperienza educativa del Collettivo G - Gramsci presso la borgata romana di San Basilio all’inizio degli anni Settanta. Attraverso l’analisi storica dell’opera-testimonianza Animazione in borgata, scritta da Maria Rita Parsi, curata da Sabina Manes e arricchita da uno scritto di presentazione di Albino Bernardini, si vuole mettere in luce la rilevanza pedagogica di un progetto che, basandosi sul teatro di “psicoanimazione”, l’attivismo pedagogico e i valori democratici del ’68, ha saputo penetrare all’interno del difficile contesto storico e sociale della borgata-quartiere di San Basilio.
L'uomo e le sue ombre. Storie, fragilità, resistenze per educare all'umiltà
In un tempo attraversato da precarietà esistenziale e crisi di senso, questo contributo riflette sul valore della narrazione, della fragilità e della memoria nella costruzione del Sé. Attraverso uno sguardo pedagogico-esistenziale, l’articolo si articola in tre movimenti: il primo esplora il legame profondo tra corpo, mente e storie di vita, rintracciando nella dimensione biografica la forza invisibile che guida il nostro agire; il secondo indaga la tensione tra identità e vulnerabilità, mettendo in luce come il passato condizioni il futuro e come solo attraverso un confronto critico con la propria storia si possa intravedere una forma di liberazione; il terzo si concentra sulla funzione generativa del racconto e sull’urgenza di una pedagogia della presenza e dell’autenticità, capace di trasformare le ferite in tracce significative.
Verso una comunità educante: l'esperienza dello spazio culturale obù a Napoli
Il presente contributo intende analizzare pratiche educative in contesti di vulnerabilità, ponendo l’accento sulla valorizzazione di tali condizioni non solo come limiti, ma anche come potenzialità. In particolare, l’articolo esplora il processo di co-costruzione del significato dello Spazio Culturale Obù, attivato a Napoli dalla Fondazione Terzoluogo attraverso un innovativo approccio di pedagogia sociale. Si analizza come questo spazio si configuri come un ambiente dinamico di relazione e apprendimento collettivo, promotore della partecipazione attiva della comunità. Infine, si evidenzia il ruolo di Obù come catalizzatore della rigenerazione del tessuto sociale e educativo locale, sottolineandone la funzione nella promozione di un’inclusione sociale sostanziale.
Il senso della meraviglia per il risveglio del cuore e al mondo, oltre il senso della vista
Il presente contributo intende offrire una lettura della tematica proposta dalla prospettiva pedagogica olistica e in considerazione del paradigma dell’embodiment. In particolare, si è voluto trattare del valore dell’esperienza estetica, dunque di una educazione attraverso la risorsa dell’universo sensoriale, nel ridestare il valore dell’intelligenza del cuore, capace di integrare discernimento e sensibilità. Sotto questo aspetto il contributo intercetta un bisogno formativo e educativo laddove l’aridità del cuore può produrre cecità di fronte alla ricchezza e al mistero dell’esperienza esistenziale e laddove la cecità da menomazione visiva richiede un intervento in grado di permettere di “vedere”. Ci siamo dunque interrogate: “vedere in che senso?”
Decostruire gli stereotipi e i pregiudizi attraverso la favola di cappuccetto rosso
La differenza fa paura quando non la conosciamo, la interpretiamo attraverso pregiudizi e stereotipi o la leggiamo scegliendo sempre la stessa voce narrante. La scuola ha l’importante compito di “formare” i cittadini di domani, uomini e donne che devono saper interagire in contesti sempre più eterogenei, muoversi tra differenti punti di vista, sovrapporre sguardi diversi. Fin dai primissimi anni di vita del bambino, le fiabe sono un importante strumento che la scuola ha a disposizione, poiché co stituiscono una via di accesso “privilegiata” al mondo interiore dell’alunno. Attraverso l’identificazione dei personaggi delle storie è possibile combattere le paure, decostruire stereotipi, indossare “abiti” diversi dal proprio. Fornire contro-narrazioni diventa, in quest’ottica, uno strumento per potenziare l’empatia, coltivare un pensiero critico, aperto al dialogo e al confronto. Un possibile esempio di decostruzione è legato alla figura del lupo, il cattivo per eccellenza nelle fiabe, basti pensare a “Cappuccetto Rosso”, “I tre porcellini”, “I sette capretti”, solo per citare alcuni nomi. Ma cosa succede se queste storie vengono lette non dal punto di vista dei protagonisti ma da quello del lupo? Siamo sicuri che la morale della storia rimane la stessa? Il lupo è così cattivo come appare?
Didattica museale e visual education come esperienze di inclusione e cura
La didattica museale e la visual education rappresentano strumenti potenti per affrontare le sfide della vulnerabilità sociale, favorendo inclusione, rigenerazione e resilienza. Attraverso esperienze estetiche e visive, è possibile stimolare l’empatia, il pensiero critico e la narrazione di sé, creando spazi di dialogo e partecipazione che valorizzano l’unicità di ogni individuo. Questo articolo esplora il potenziale trasformativo di tali approcci, presentando esempi possibili di laboratori artistici e progetti rivolti a comunità vulnerabili, come rifugiati, migranti, giovani in situazioni di marginalità e a persone con disabilità. Si riflette inoltre sulle sfide etiche e metodologiche, evidenziando l’importanza della co-progettazione e del coinvolgimento attivo dei partecipanti. Infine, si propongono prospettive future per integrare la didattica museale e la visual education in percorsi educativi multidisciplinari, promuovendo una società più inclusiva e consapevole.
L'educazione come strumento di trasformazione: dalla vulnerabilità all'inclusione sociale
La vulnerabilità, spesso associata a mancanza e fragilità, può invece divenire una chiave di trasformazione educativa. L’aforisma “Si vede bene solo con il cuore” invita a riconoscere il valore di ciò che resta invisibile, ripensando le logiche educative dominanti e dando voce a prospettive marginalizzate. In contesti di fragilità sociale, questa prospettiva apre spazi per pratiche pedagogiche capaci di generare cambiamento, consentendo alle esperienze escluse di emergere e trasformare la vulnerabilità in risorsa. Il presente articolo esplora tale potenzialità, interrogandosi sul rischio di cristallizzare la vulnerabilità in categorie rigide e sull’importanza di approcci educativi che restituiscano agency e autodeterminazione ai soggetti coinvolti.
Liceali e migranti a confronto tra i banchi: l'esperienza didattica presso la scuola Penny Wirton
L’integrazione e la promozione sociale godono dello statuto di prerequisiti all’interno del sistema scolastico italiano. Tuttavia, grazie alla precipua intuizione didattica della scuola Penny Wirton e alla strutturazione di un oculato percorso per lo sviluppo delle competenze trasversali e dell’orientamento secondo il paradigma del Liceo classico statale Giulio Cesare, essi giungono facilmente a costituire un prezioso strumento didattico capace d’inverare un curriculum formativo capace di coniugare alle abilità linguistiche i valori della solidarietà e della sussidiarietà, entro l’orizzonte del bene comune.
I Care. Un'esperienza progettuale per una scuola che si prende cura
Il contributo proposto ha l’obiettivo di condividere un’esperienza progettuale realizzata in una scuola secondaria di secondo grado, situata nella periferia sud di Milano, nella quale sono presenti una percentuale consistente di situazioni di marginalità a rischio di dispersione scolastica. Il progetto, dal titolo I care, ispirandosi al celebre motto di Don Lorenzo Milani, ha la finalità di coinvolgere nell’azione di cura educativa, gli studenti del quinto anno dell’indirizzo tecnico informatico che, attraverso la metodologia del peer to peer, hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze tecnologiche per creare del materiale didattico utile agli studenti e alle studentesse che frequentano il secondo anno dell’indirizzo professionale per i servizi e la sanità dello stesso istituto.
La relazione educativa come pedagogia sociale agita: uno studio esplorativo
Nel corso degli anni, la figura dell’educatore ha visto una grande difficoltà nella definizione della propria identità professionale, in quanto orientato ad operare con una varietà e complessità di ambienti e bisogni diversificati. Relazione, ricerca e mediazione, tuttavia, rappresentano, elementi cruciali della competenza educativa, in quanto caratteristici dell’azione pedagogica. Tra le tante declinazioni, il presente contributo pone una riflessione, attraverso la narrazione di un’intervista condotta in un’esperienza di Erasmus +, sull’importanza cruciale della professionalità educativa nel contesto comunitario, a partire dalla relazione di cura, fino alla determinazione di un bene comune, insito nelle pratiche di istruzione, formazione e socializzazione.
Il progetto micropolis come modello educativo integrato
Il contributo esplora il potenziale generativo e trasformativo della vulnerabilità sociale nel contesto del progetto Micropolis, attivo in tre aree siciliane segnate da povertà educativa. La ricerca-azione, condotta dal gruppo di Didattica e Pedagogia speciale dell’Università degli Studi di Enna “Kore” nell’ambito del progetto, si è svolta in micro-spazi concepiti come contesti dinamici di prossimità. Articolata in tre fasi – osservazione partecipata, formazione dialogica, elaborazione di materiale divulgativo e didattico – essa ha coinvolto operatori, famiglie e bambini nella co-costruzione di pratiche situate e inclusive. La vulnerabilità è assunta come chiave di lettura pedagogica, attraverso cui attivare processi relazionali e generare forme di giustizia socio-educativa.
Sostegno alla genitorialità in contesti vulnerabili. Un'esperienza di co-ricerca e pratica didattica
Il contributo descrive un’esperienza di ricerca-azione condotta dall’Istituto comprensivo di Cariati, finanziata dal PNRR (DM 170/2022) e mirata a prevenire la dispersione scolastica attraverso il supporto alla genitorialità e il coinvolgimento della comunità locale. Il progetto ha utilizzato mentoring e tutoring per famiglie vulnerabili, integrando risorse istituzionali e del terzo settore, in risposta ai bisogni educativi e alle fragilità di contesto emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) della scuola.
Vulnerabilità adolescenziali: lavorare in un servizio educativo semiresidenziale
Il lavoro dell’educatore all’interno dei servizi socioeducativi dedicati agli adolescenti vulnerabili è complesso ed emotivamente impattante. Infatti, è caratterizzato non tanto da un fare quanto da un esserci con l’altro. In questo contributo viene descritta una ricerca fenomenologico-ermeneutica con gli educatori di un centro diurno semiresidenziale che accoglie adolescenti fragili, collocato in un capoluogo di regione del centro Italia, volto a favorire e sostenere una riflessione da parte degli educatori sulle pratiche educative in un contesto connotato dalla vulnerabilità, attraverso l’esplorazione dei loro vissuti.
L'impatto della pratica sportiva sui giovani vulnerabili: una ricerca di follow-up
L’articolo, sottolineando la rilevanza di dedicarsi alle fasce più deboli della società, anche per quanto riguarda la ricerca scientifica, esplora l’utilizzo delle attività motorie e sportive come strumento educativo atto a promuovere l’inclusione sociale e a migliorare la qualità di vita dei giovani in condizione di disagio. La ricerca presentata indaga se e come lo sport possa avere un impatto sulla vita di questi giovani. I risultati evidenziano come, in alcuni casi, lo sport abbia dotato i giovani di nuove esperienze, una visione rinnovata di sé e del mondo, un maggiore capitale sociale, influendo a volte sulla loro traiettoria di vita. Tuttavia, si sottolinea che il successo, comunque difficile da determinare, dipende in realtà da diversi fattori.
Aprire il dialogo a scuola: un'esperienza di ricerca in una periferia milanese
Il contributo riflette sulla vulnerabilità adolescenziale nel panorama contemporaneo con particolare attenzione ai giovani con background migratorio in contesti di povertà educativa. In questo scenario, la scuola assume un ruolo centrale come potenziale spazio di crescita e inclusione se si rivela in grado di promuovere processi di dialogo intergenerazionale e interculturale. Vengono discussi in particolare gli spunti provenienti dall’esperienza di Cantieri di dialogo, azione pilota realizzata all’interno del progetto Reinventare la cittadinanza (FAMI 3867), volta a promuovere azioni innovative di dialogo e partecipazione democratica in una scuola secondaria del quartiere San Siro di Milano.
La scuola come spazio di riscatto. Inclusione, fragilità e nuove sfide educative
L’articolo esplora il ruolo cruciale della scuola come spazio di rigenerazione sociale e culturale in risposta alle crescenti forme di vulnerabilità sociale. Attraverso un approccio pedagogico inclusivo e critico, si evidenzia l’urgenza di superare i modelli educativi assimilazionisti, valorizzando invece le diversità e promuovendo la giustizia sociale. Richiamandosi alle esperienze di Freire, Milani e Montessori, il testo propone un’educazione orientata all’emancipazione e alla cittadinanza attiva. La scuola è chiamata a costruire alleanze educative per contrastare esclusione, precarietà e diseguaglianze.
Tempo flessibilie e rigenerazione educativa: riorganizzazione oraria in una scuola secondaria di primo grado
L’articolo presenta i primi risultati di un’indagine longitudinale sull’impatto dell’organizzazione flessibile del tempo scuola in una secondaria di primo grado. La ricerca evidenzia che la riorganizzazione oraria favorisce lo sviluppo di competenze personali, di autoregolazione e strategie di apprendimento degli studenti, migliorandone motivazione, concentrazione e atteggiamento verso la scuola, contribuendo al benessere complessivo e riducendo il rischio di abbandono scolastico.
MAB: un metodo per facilitare autonomia, relazioni e apprendimento in contesti di esclusione sociale
Il contributo esplora il Metodo Analogico di Camillo Bortolato (MAB) come approccio pedagogico innovativo per l’inclusione sociale in contesti di vulnerabilità. L’obiettivo è analizzare come il MAB promuova l’educazione in quanto atto di cura, valorizzando autonomia, relazione e apprendimento. La metodologia dell’articolo si basa su una revisione della letteratura e un caso studio. Le ricerche preliminari mostrano un impatto significativo del MAB sulle abilità numeriche, motivazione e attenzione, configurandosi come un approccio promettente e innovativo per un apprendimento efficace e inclusivo.
Vulnerabilità, povertà educativa, inclusione
L’articolo esplora il tema della povertà educativa, le cui ripercussioni si estendono oltre l’ambito scolastico, alimentando disuguaglianza ed esclusione col rischio di esporre alla dipendenza economica, sociale e culturale alcuni individui rispetto ad altri. Contrastarla costituisce un impegno a tutela della libertà e dell’uguaglianza delle opportunità e una strategia vincente perché rafforza il capitale umano e favorisce inclusione e coesione. La via maestra indicata muove da un’interpretazione positiva della condizione di vulnerabilità che apre alla possibilità di sperimentare pratiche educative e policies mirate alla cura dei singoli affinché sviluppino il loro pieno potenziale e diventino parte attiva e responsabile della società.
Narrazioni di vulnerabilità: uno studio di caso sulla dispersione scolastica in Campania
Il presente studio di caso, condotto in una scuola secondaria di secondo grado della Campania ad alto rischio di dispersione scolastica, indaga le vulnerabilità sociali (Rumberger, 2011; Batini, 2023). L’analisi dei focus group rivolti agli studenti e delle interviste a docenti e Dirigente Scolastico rivela fragilità socioeconomiche, culturali e relazionali (Batini, 2014; Dell’Anna & Ianes, 2021). I risultati evidenziano l’importanza di relazioni educative autentiche e dell’ascolto attivo (Rogers, 1970) per intercettare i bisogni formativi. Dalle narrazioni dei partecipanti, la scuola emerge come potenziale spazio di rigenerazione umana e culturale, capace di offrire supporto e prospettive. La ricerca invita a riflettere sulla vulnerabilità educativa per lo sviluppo di interventi inclusivi contro la dispersione.
Sostenere i Siblings. Vulnerabilità, vissuti emotivi, percorsi educativi
I siblings vivono esperienze complesse caratterizzate da specifiche vulnerabilità. La loro quotidianità è segnata da sentimenti contrastanti: dall’amore incondizionato alla frustrazione, dal senso di responsabilità alla percezione di essere in secondo piano nelle dinamiche familiari. Il dolore dei siblings può manifestarsi attraverso difficoltà relazionali, sensi di colpa e preoccupazioni sul futuro. I percorsi educativi dedicati a loro dedicati si configurano come occasione per elaborare questi vissuti e sviluppare forme di resilienza. Percorsi psicoeducativi, esperienze narrative, supporto emotivo ed educazione alla genitorialità rappresentano interventi efficaci per trasformare la vulnerabilità in risorsa, valorizzando il ruolo unico che i siblings ricoprono e promuovendo la qualità della vita.
L'incontro educativo come strumento di cambiamento nei contesti di vulnerabilità
L’articolo esplora il tema della fragilità sociale negli ambienti formativi, proponendo una rilettura critica della vulnerabilità come spazio generativo anziché deficitario. Attraverso una prospettiva interdisciplinare che attinge alla filosofia, alla sociologia e alla pedagogia critica, si sostiene che l’interazione con l’altro – in contesti segnati da disuguaglianze – rappresenti un’esperienza relazionale capace di attivare processi trasformativi individuali e collettivi. La vulnerabilità, lungi dall’essere ridotta a condizione da gestire tecnicamente, emerge come ambiente educativo in cui empatia, solidarietà e riconoscimento reciproco diventano princìpi fondanti per una pedagogia inclusiva. L’incontro con l’altro, in questa ottica, si configura come fulcro di una pedagogia della speranza, dove la fragilità si trasforma in risorsa per co-costruire sapere e promuovere giustizia sociale.
Prendersi cura di soggetti senza fissa dimora. Una ricerca nella città di Bari
L’attività degli operatori che lavorano con persone in condizioni di estrema marginalità si configura come lavoro sociale o social work, operando in contesti che richiedono contatto diretto ed esposizione a rischi fisici e psicologici. Essi creano percorsi di cura e cambiamento per il benessere degli assistiti, affrontando sfide legate a politiche sociali, risorse finanziarie e trasformazioni demografiche. A partire da un progetto di dottorato presso l’Università degli Studi di Bari, il presente contributo analizza i bisogni formativi degli operatori locali, con un’indagine sulle loro aspettative professionali. I risultati hanno portato allo sviluppo di un progetto formativo specifico per chi lavora con persone senza dimora, supportato da enti locali.
La comunità di apprendimento: uno studio di caso nella scuola Di Donato di Roma
Molti studi mostrano una relazione positiva tra il rendimento degli studenti e la partecipazione della famiglia alla vita scolastica. La partecipazione delle famiglie può rappresentare un beneficio anche per l’intera comunità scolastica, contribuendo a condividere la responsabilità nei processi educativi e formativi. Il contributo prende in esame le motivazioni e gli obiettivi pedagogici e metodologici delle comunità di apprendimento che da più di venti anni sono andate consolidandosi con sempre maggiore frequenza all’interno del panorama educativo iberoamericano. Situando tale progetto all’interno della riflessione teorica circa la crescente importanza di un’educazione diffusa e continua lifelong, lifewide, lifedeep, necessaria per promuovere una cittadinanza attiva nell’attuale società dell’informazione, s’intende approfondire tanto il quadro concettuale che le buone pratiche che caratterizzano questa progettualità. Al contempo, attraverso uno studio di caso presso la scuola primaria Di Donato di Roma, vengono messi in evidenza anche alcuni possibili limiti e problemi che tale progetto comporta e, di contro, la possibilità di ovviarli assumendo solo parzialmente la metodologia originaria.